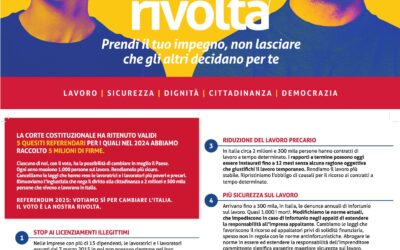Una legge, quella Calderoli, che aumenta o crea disparità nel Paese, con una pericolosa differenza tra Regioni di serie A e di serie B
Una legge, quella Calderoli, che aumenta o crea disparità nel Paese, con una pericolosa differenza tra Regioni di serie A e di serie B
Ogni volta che si discute, sia pure in un circolo ristretto, su provvedimenti che avranno un impatto sulla collettività, ritengo si avanzi, sia pure a fatica, verso quel modello di sviluppo sociale di cui siamo promotori e che ha come faro la Costituzione. L’incontro sull’Autonomia differenziata tenutosi al Circolo “Raffaele Marcolli” del Partito Democratico di Induno Olona Valmarchio si inserisce appunto in questo contesto.
Nella discussione un punto di riflessione che accomunava tutte e tutti, al di là delle questioni di merito, è che la riforma Calderoli presenta delle aree di ambiguità tanto da lasciare aperti degli interrogativi anche fra gli stessi sostenitori della legge. Ma proviamo ad entrare insieme in alcuni aspetti della Legge Calderoli.
Vi sono materie non sottoposte alla definizione dei LEP, per le quali le Regioni potrebbero (fermo restando le diverse intese) vedersi attribuita sin d’ora una competenza legislativa in via esclusiva senza alcun vincolo unitario. Tant’è che Lombardia, Veneto, Liguria, e Piemonte, hanno già avuto un primo incontro interlocutorio con il governo. Forse incomincia a prendere forma il sogno di bossiana memoria?
Per quanto riguarda, invece le materie subordinate alla determinazione dei LEP, la norma ha previsto che essi vengano identificate da una cabina di regia, ad oggi presieduta da Sabino Cassese, in base ad una ricognizione storica della spesa e delle funzioni esercitate nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. La cabina di regia, a sua volta ha nominato una commissione tecnica con il compito di stabilire dei criteri per identificare i fabbisogni standard e quindi i costi dei LEP.
E sono appunto questi criteri a creare differenti condizioni, se a determinare i LEP sono:
– le condizioni e il costo della vita nelle regioni
– il territorio
– gli aspetti sociodemografici della popolazione residente
– il clima.
Si afferma in tal modo che i bisogni non sono uguali, con buona pace dei diritti uguali per tutti come previsto dalla Costituzione. Cristallizzando differenze e disparità esistenti. E se, come pare, i criteri saranno legati a specifiche differenze territoriali, queste si chiamano gabbie salariali di passata memoria.
Inoltre, a mio avviso è in corso un’iniziativa politica ben precisa che utilizza una commissione tecnica per fissare i livelli essenziali in maniera differenziata e soprattutto determinandoli ai livelli più bassi possibili, specialmente al Sud, in modo da renderli compatibili con gli attuali assetti di bilancio. Quali prestazioni, quali servizi debbano essere definiti essenziali, è una scelta politica che rimanda ad un modello di sviluppo economico sociale e in questo caso emerge un profilo di doppia discriminazione per il Sud, già discriminato dal processo di deindustrializzazione, dalla debolezza delle reti e delle sue infrastrutture.
Per quanto riguarda la sanità, le già evidenti disparità fra regioni con la riforma verrebbero ulteriormente acuite. Basti pensare per es. alla carenza del personale medico. Una regione per farvi fronte potrebbe pagarli di più reclutandoli da altre regioni che non possono garantire lo stesso trattamento.
Fra le tante tematiche, forte è la nostra contrarietà sulla scuola. Il rischio è infatti che l’attuazione del compito costituzionale sia subordinato alle diverse disponibilità economiche e scelte locali. Come per i medici, l’autonomia differenziata potrebbe avere un impatto sul reclutamento, sulla formazione, sulla retribuzione del personale scolastico. Oltre al fatto che regionalizzare la scuola, potrebbe anche voler dire avere dei programmi scolastici diversi nei diversi territori.
Oltre a ciò, se dovesse passare questo principio nei contratti pubblici, il privato non resisterebbe a lungo. E finiremmo in breve a prima del 1969 e dell’autunno caldo. Senza contare quanto tutto questo indebolirebbe il CCNL quale strumento di solidarietà per eccellenza.
In aggiunta, una fra le diverse questioni che rimangono aperte è come si decide il riallineamento delle risorse. Si parla di LEP e non della questione finanziaria che invece costituisce il punto centrale dell’autonomia, cioè qual è l’aliquota di compartecipazione? In breve, quante tasse rimangono sul territorio? Questa aliquota verrà fissata annualmente dalla Commissione paritetica dopo la firma dell’intesa.
Ma vale la pena evidenziare che le commissioni sono una per regione e quindi ci sarà una trattativa privata caso per caso.
Infine, nel merito della legge non viene menzionato il Fondo di Solidarietà e di Perequazione che è invece un principio cardine dell’art. 119 della Costituzione.
Oggi l’80% del calcolo delle pensioni avviene con il sistema contributivo. Itinerari previdenziali secondo gli ultimi dati dell’Inps (fonte L’economia del “Corriere della Sera” del 7 ottobre 2024, quindi non una fonte Cgil) segnala che su circa 280.000 italiani/e usciti con la pensione di vecchiaia nel 2023 solo 100.000 avevano i contributi pieni mentre per quanto riguarda la restante parte una buona metà non avrà più di 300,00 euro al mese. Si profila quindi, cito testualmente, una nuova categoria: i “retired poor”, logica conseguenza dei “working poor”.
Questa è la nuova emergenza politica e sociale che tenderà sempre più ad aumentare nel corso degli anni e che richiede interventi strutturali per garantire una maggiore equità pensionistica, a partire da adeguate politiche sul lavoro a contrasto della precarietà.
Nella legge di bilancio si parla di rafforzare il secondo pilastro, misura che di per sé potrebbe essere condivisibile se non fosse che la spinta verso l’Autonomia differenziata, oggi sposta l’asse sempre più dalla previdenza pubblica ai fondi privati. Inutile sottolineare quanto pericoloso sia lasciare la gestione dei fondi a livello regionale sganciandoli dalla normativa nazionale.
Il messaggio secondo il quale l’Autonomia differenziata è un’opportunità per il sistema industriale e produttivo, viene smentito nei fatti, dato che essa non potrà che indebolire ulteriormente l’assetto industriale e produttivo. Oggi l’economia è globale e la competizione avviene su scala continentale, e quindi delegare materie fondamentali come la ricerca, lo sviluppo tecnologico alle regioni, produrrà effetti ancora peggiori su di un sistema già fortemente in crisi. Lo stesso vale per la comunicazione, nell’epoca di internet globale e dell’IA.
In una sfida che riguarda i continenti, noi viaggeremo in ordine sparso a livello regionale. Su materie che richiederebbero una regia nazionale e investimenti enormi in ricerca e innovazione e per le quali si dovrebbero predisporre politiche industriali comuni a livello europeo, noi ragioniamo in termini di confini sempre più circoscritti.
La storia insegna, ma non a tutti!
Mimma Agnusdei, Segreteria Cgil Varese